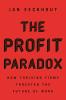Interviews
La rivincita della mano visibile. Il modello economico asiatico e l’Occidente

“La rivincita della mano visibile” potrebbe essere definito un libro su questi anni: leggendolo viene da pensare ad altri sullo stesso argomento, ad esempio “Il mondo è guasto” di Tony Judt (Editore Laterza) e “La grande contrazione . I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto” di Mauro Magatti (Feltrinelli). Tuttavia, a differenza delle due opere citate, Mazzei e Volpi non limitano il loro sguardo al pensiero occidentale ma considerano ampiamente anche la cultura orientale. Questa intenzione è sostenuta nelle prime pagine dell’introduzione: « La nostra tesi si articola in due punti. Primo, questa crisi non è affatto congiunturale,…, ma una crisi sistemica,…., essa si inquadra in un fase di trasformazione epocale del Sistema Internazionale: la fine del predominio dell’Occidente. Il secondo punto, di natura epistemologica, implica il superamento dell’opposizione “Stato – Mercato” a favore di un approccio win – win (a somma positiva) che… dovrebbe portare, normativamente, a un mutamento radicale del nostro modello di sviluppo da una dimensione essenzialmente quantitativa a una dimensione più qualitativa». «Ed è sulla base di questa profonda convinzione che vorremmo presentare alcune riflessioni riguardanti l’evoluzione storica di questo complesso rapporto tra Mercato e Stato, tra “mano invisibile” e “mano visibile”, con riferimento alla diversa evoluzione – rispetto all’Occidente – che esso ha avuto nell’Asia Confuciana».
I due Autori riprendono i due princìpi della cultura orientale: ying, principio femminile e yang principio maschile. Nell’Asia confuciana, ying e yang non sono forze che si escludono a vicenda. Esse sono complementari e si alternano e si equilibrano. «Quindi, la notte esiste, in quanto esiste il giorno,…e - parafrasando Adam Smith – il mercato esiste perché esiste lo Stato. Quindi il Confucianesimo (yang) esiste perché esiste il suo opposto: il taoismo». «Evidenti sono le divergenze sul piano politico tra queste due tradizioni culturali. Allo Stato interventista e paternalista del burocrate confuciano (mandarino) corrisponde lo Stato inattivo dei taosti».
A partire dalla “pluralità” del Capitalismo, nella prima parte del libro, questa relazione tra Mercato e Stato è descritta e analizzata, nel tempo e nello spazio: partendo dall’epoca keynesiana fino alla paradigma neo liberale di questi ultimi quarant’anni. I titoli dei capitoli documentano, in estrema sintesi, le considerazioni svolte: l’accumulazione fordista, crisi dello Stato e rivincita del mercato, toyotismo, il capitalismo anglosassone, Giappone e Germania: due paesi un capitalismo, il capitalismo socialista cinese, il polo confuciano e lo Stato sviluppista. La seconda parte, fondamentalmente analitica, è dedicata a Cina, Giappone e Corea.
Un libro ricco nel quale s’intrecciano modelli di pensiero e indirizzi adottati nel campo politico economico in Oriente e Occidente.
Una pagina significativa, da questo punto vista, è quella dedicata alle radici storiche della “mano invisibile”: «a questo punto preme sottolineare che l’idea di una “mano invisibile”, che storicamente si fa risalire allo stoicismo dell’antichità, non è affatto un’esclusiva del pensiero europeo. Secondo alcuni studiosi, Adam Smith, nella teorizzazione del laissez faire, si sarebbe in qualche modo indebitato con la tradizione taoista cinese, tramite la mediazione dei fisiocratici francesi e, segnatamente, di Quesnay, uno dei maggiori sinofili del tempo e noto come il “Confucio d’Europa” con il quale ebbe contatti durante la sua visita in Francia. Detta in breve, l’espressione francese laissez faire, sarebbe stata modellata sul principio base del Taoismo: il wou-wei, “non agire”».
Nel libro si trovano anche considerazioni, spesso espresse in maniera sintetica, in uno stile da pamphlet, che, dopo una prima lettura, si desidera approfondire ma che sono utili per analizzare ed anche porsi interrogativi sul recente dibattito politico – economico in Italia e in Europa. Un primo esempio è fornito dal giudizio dato dagli Autori sul capitalismo “consensuale” tedesco, il cui paradigma poggia «sulla dottrina della “economia sociale di mercato”, i cui fondamenti furono enunciati nel 1949 dai padri fondatori del modello tedesco W. Ropke, W. Euken e A. Muller-Armach. «L’ambizione della economia sociale di mercato è quella di costruire e garantire un ordine concorrenziale che offra un’opportunità per tutti gli agenti economici e benessere per il massimo delle persone. Dato che lo Stato è obbligato – attraverso la costituzione tedesca – a garantire l’ordine concorrenziale, l’eterna opposizione tra Stato e Mercato è così trasformata in elemento costruttivo – ciò che differenzia la soziale Marktwirtschaft dagli altri modelli di capitalismo». Mazzei e Volpi giudicano questa dottrina: “invero un po’ ambigua”. Viene da chiedersi quale è l’opinione del prof. Monti, bocconiano come i due Autori, su questo giudizio. E’ da ricordare che l’ex Presidente del Consiglio italiano, come riportato nella stampa, ad una precisa domanda di Obama sul modello tedesco ha risposto dicendo che per comprendere la visione politico – economica della Germania, più che ad Adam Smith occorre fare riferimento ai princìpi della filosofia morale.
Il secondo esempio è relativo ai modelli (o varianti, a partire da quello renano assunto come riferimento) di capitalismo presenti nell’Europa Continentale. «Le principali varianti identificate dagli specialisti sono: tedesca, nordica, mediterranea, postsocialista. Tuttavia esso ha la sua specificità al Centro e al Nord Europa: Germania, in primis, poi Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia. Difficile appare la collocazione del capitalismo italiano in questo contesto: pur condividendo alcuni elementi del modello renano (in particolare il ruolo delle banche e il ruolo dell’impresa, soprattutto delle PMI) esso appare più vicino al “capitalismo mediterraneo”. Questa variante, che si estende a Grecia, Spagna e Portogallo, sarebbe caratterizzata essenzialmente dalla complementarietà tra una protezione sociale meno sviluppata rispetto al modello renano e a un alto livello di regolamentazione dei mercati di beni, di servizi, e segnatamente del lavoro». Queste considerazioni sono importanti in quanto aiutano a spostare il dibattito europeo da considerazioni morali (paesi virtuali e paesi che tali non sono), a un confronto fra modelli diversi che tengono conto di differenti contesti culturali, storico e geografici.
Rilevante nella quotazione soprariportata l’accenno alla protezione sociale meno sviluppata e all’alto livello di regolamentazione del mercato del lavoro. Questi accenni, se sviluppati, permetterebbero di arricchire il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro.
Un’ultima notazione. Ciascun capitolo del libro è corredato da ampie note bibliografiche: è da notare che non pochi fra gli Autori quotati appartengono alla scuola francese. Una scuola e una nazione che ha ben chiaro il ruolo della “mano visibile” e che ha saputo conservare e sviluppare un legame con il pensiero orientale, cinese in particolare, iniziato nel Settecento, come documentato dal prestito del concetto di “mano invisibile”.
Reviews and Reflections
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser