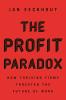Interviews
Il management dei teatri lirici. Ricerca degli equilibri e sistemi di misurazione

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del D.lgs. 29 giugno 1996 n. 367, recante “Disposizioni per la trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”, si è segnato il passaggio da un sistema in cui lo Stato e gli enti pubblici avevano, per così dire, il “controllo” dell’attività lirica e concertistica (definita, per l’appunto, dalla precedente legge in materia, legge 800/67, “attività di rilevante interesse generale”), ad un sistema in cui l’esercizio di tale attività viene trasferito ad organizzazioni private senza scopo di lucro.
La trasformazione dei teatri lirici da enti autonomi a fondazioni private costituisce un fatto di grande importanza, in quanto ha avviato un processo di cambiamento organizzativo e manageriale - come è avvenuto per altre attività nel campo dei beni culturali - volto all’introduzione di logiche e pratiche gestionali orientate all’ottenimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia nell’impiego delle risorse, senza incidere sui livelli qualitativi della produzione artistica.
Con l’aziendalizzazione dei teatri lirici si è data una svolta alle modalità di funzionamento delle istituzioni culturali, creando i presupposti per affermare alcuni principi di matrice economico-aziendale e, conseguentemente, alcune tra le più importanti metodologie di management.
Un’attenta analisi dei tratti salienti del processo di trasformazione verso una corretta gestione manageriale dei teatri lirici è l’oggetto del volume Il management dei teatri lirici, di Fabio Donato.
L’Autore si misura fin da subito con una certa carenza di studi aziendalistici sul tema. Prescindendo, infatti, dai contributi di matrice umanistica e sociologica, la letteratura in tema di imprese culturali e, tra queste, di teatri lirici, mostra, in effetti, un quadro conoscitivo fortemente sbilanciato sul fronte di studi che si trovano nell’alveo dell’economia generale; questi ultimi, finalizzati ad approfondire le relazioni tra economia e cultura, si sono occupati prevalentemente, da un lato, di giustificare l’intervento dello Stato nella gestione delle performing arts, dall’altro di verificare gli impatti socio-economici su un territorio (flussi turistici, localizzazione di nuove attività economiche, malessere/benessere urbano, ecc.) della produzione culturale.
Solo recentemente, soprattutto in Italia in cui il processo di trasformazione verso logiche di gestione manageriali si è compiuto negli ultimi anni, le organizzazioni teatrali sono state studiate secondo un approccio economico-aziendale. L’applicazione dell’approccio economico-aziendale allo studio dei teatri lirici può fornire un importante contributo sia per analisi di tipo positivo, finalizzate a comprendere il funzionamento delle istituzioni culturali, sia per analisi di tipo normativo, volte cioè a cogliere le criticità gestionali e suggerirne le possibili soluzioni.
E’ appunto in questa prospettiva che si colloca il lavoro di Fabio Donato, il quale si fonda sull’idea che la gestione del processo di cambiamento cui sono sottoposti i teatri lirici debba partire in primo luogo dalla definizione di un importante sistema di misurazione della performance in grado di fare emergere le criticità gestionali più rilevanti.
L’adozione di questo approccio di analisi, che si focalizza all’interno dei molteplici aspetti della gestione aziendale sui sistemi di misurazione, rappresenta uno dei tratti distintivi del lavoro di Fabio Donato.
Secondo una prospettiva economico-aziendale, una corretta gestione di un’impresa richiede certamente l’adozione di appropriati sistemi di misurazione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività e dei processi della catena del valore aziendale. E’ inoltre comunemente riconosciuto, dalla dottrina e dalla pratica manageriale, che il sistema di misurazione diventa anche coessenziale ai processi di formulazione delle strategie (in quanto consente di definire gli obiettivi aziendali in modo coerente con le risorse disponibili), nonchè di valutazione ex ante ed ex post della gestione strategica dell’impresa.
Fabio Donato, in questo lavoro, accentua proprio la “valenza strategica” dei sistemi di misurazione, sostenendo che occorre “impostare le strategie a lungo termine e le politiche gestionali di breve termine a partire da un appropriato sistema di misurazione” (pag. 18). L’Autore si riferisce ad un sistema di misurazione globale e multidimensionale, che accosti indicatori/descrittori quantitativi e qualitativi e che sia pertanto in grado di rappresentare i molteplici equilibri/obiettivi cui il sistema-teatro lirico deve tendere (gli equilibri economico-finanziari, gli elementi intangibili quali la qualità delle produzioni artistiche, gli equilibri della coesione sociale con gli stakeholders, la capacità di attrazione degli artisti, ecc.).
La valenza strategica del sistema di misurazione è ancora più marcata quando si stanno affrontando le criticità del passaggio e della trasformazione di una particolare categoria di aziende - i teatri lirici - da una gestione orientata solo alla cultura ad una gestione orientata al raggiungimento di obiettivi istituzionali artistici (efficacia) in un quadro, tuttavia, di rispetto dell’equilibrio economico-finanziario (efficienza); tale passaggio necessita inevitabilmente di una fase di approfondita ricognizione (sino ad ora effettuata in modo a-sistematico) delle risorse, dei processi, e del livello di efficienza ed efficacia da essi raggiunti, al fine di consentire ai diversi livelli dirigenziali di un teatro lirico di avere un quadro complessivo degli andamenti dell’organizzazione e favorire, in tal modo, i relativi processi decisionali.
Un secondo aspetto di originalità riguarda la metodologia di indagine utilizzata, che è quella del metodo dei case history. Il testo, infatti, si fonda su un approfondito studio della Royal Opera House di Covent Garden di Londra e del Teatro dell’Opera di Roma. Il metodo è quindi induttivo, in quanto il fenomeno viene indagato risalendo dalla dimensione specifica alla dimensione generale (o globale).
In conclusione, il volume propone analisi e spunti di riflessione atti a cogliere alcune rilevanti criticità del processo di trasformazione dei teatri lirici e a enucleare i sistemi di misurazione e i relativi indicatori più appropriati per affrontare le problematiche del processo di cambiamento in atto.
Tali riflessioni sono funzionali a fare comprendere anche i percorsi strategici più appropriati per i teatri lirici, finalizzati al conseguimento di livelli di eccellenza della prestazione artistica, senza tuttavia penalizzare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari. E ciò significa, in definitiva, riuscire a contemperare sia una visione “tradizionale” secondo cui i teatri lirici svolgono un ruolo sociale (in quanto agenti diffusori di cultura nella collettività), sia una visione “d’impresa” secondo cui il teatro lirico è un soggetto che ricerca un’eccellenza avente anche un risvolto “strategico”, che si traduce cioè nella produzione di valore e nel raggiungimento di vantaggi competitivi difficilmente replicabili dai competitors.
Reviews and Reflections
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser