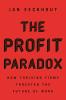Interviews
Mondializzazione: come fanno per competere? Cosa stanno facendo le imprese di tutto il mondo per vincere la sfida della nuova economia

La globalizzazione economica è un tema in cima all'agenda del dibattito pubblico; sempre più numerosi sono i commentatori che, attraverso il sistema dei media, ci propongono previsioni e scenari macro-economici e sociologici, valutazioni sugli effetti positivi e negativi, paragoni storici e quant’altro. A fronte di posizioni anche radicalmente contrastanti, spesso ideologiche, for global, no global e new global tendono in genere a concordare su un punto: l'intensificarsi dell’economia globale e della competizione transnazionale impongono progressivamente condotte omogenee agli attori economici, imprese in primo luogo, e a quelli che hanno compiti di governance di tali processi. The World is Flat, afferma un noto columnist del New York Time nel suo best-seller di fama mondiale.
Si possono trovare sostenitori di questa tesi anche tra gli studiosi di varie discipline (economiche, aziendali, organizzative ecc.); in particolare, chi si ispira alla teoria economica mainstream prevede che all'interno di ogni settore industriale le pratiche organizzative e le strategie di business tenderanno a convergere, grazie all’azione dei meccanismi di produzione dell'isomorfismo; inoltre, nel lungo termine si assisterà al tramonto di quei settori e prodotti che sono labour-intensive, perlomeno nei Paesi in cui i salari sono più elevati.
Ma su quanti e quali dati empirici si basano queste aspettative? Ci si aspetterebbe un fiorire di ricerche, di vario taglio disciplinare; invece, quando dall'affollato piano dei ragionamenti deduttivi si passa a quello del confronto con i fatti, la folla si dirada. Qui si colloca la ricerca, di cui il libro in oggetto dà conto, svolta tra il 1999 e il 2004 da un'équipe di ricercatori del MIT di Boston guidata da Suzanne Berger. I ricercatori si sono chiesti se il modello della convergenza costituisca una adeguata interpretazione dei comportamenti effettivi delle imprese di fronte alle sfide della globalizzazione. Per trovare la risposta, hanno condotto circa 600 interviste in profondità a imprenditori e manager di più di 500 aziende del Nordamerica, dell'Asia e dell'Europa, appartenenti a diversi settori industriali, da quelli fast-tech (ad esempio l'elettronica) a quelli slow-tech (come il tessile). Oggetto dei colloqui sono state le scelte effettuate in tema di outsourcing e di delocalizzazione: quali fasi della produzione sono rimaste in impianti di proprietà e quali sono state esternalizzate? Quanti posti di lavoro si sono persi in patria e quanti creati all'estero? Quali strategie di marketing e quali scelte logistiche sono state adottate? Quali scelte si rivelano vincenti nel lungo termine?
Berger e colleghi sono giunti alla conclusione che la tesi della convergenza non rende conto di quanto sta avvenendo sul fronte della competizione globale. I risultati empirici, osserva l’Autrice, mostrano al contrario una grande e persistente eterogeneità nelle strategie delle imprese: alcune optano per l'integrazione verticale; altre esternalizzano fino a dar luogo a una frammentazione estrema; altre ancora si concentrano in un ristretto ambito geografico e collaborano con uno scambio intenso e continuo di conoscenze, competenze e talenti specialistici. Quali sono i fattori che spingono in direzione dell'eterogeneità e quelli che la rendono possibile?
Chi conosce i lavori precedenti dell’Autrice sa che la sua opposizione alla tesi della convergenza non è maturata durante questa ricerca. Berger è stata una delle protagoniste del dibattito sulla varietà dei modelli capitalistici, iniziato verso la fine degli anni Ottanta, insieme a studiosi come Soskice, Dore, Streek, Regini e altri ancora. Oggi tuttavia, sulla base di questa nuova indagine, anche la tesi delle varianti nazionali le pare inadeguata a rendere conto della varietà delle risposte imprenditoriali, vincenti, alle pressioni del mercato globale. L'approccio delle varianti nazionali, al pari di quello della convergenza, parte da un'analisi macro del funzionamento e del cambiamento delle economie; quindi procede a dedurre le probabili reazioni di individui e imprese sottoposti alle stesse pressioni. Ma non ne studia le risposte effettive. I comportamenti registrati con le interviste mostrano invece che il patrimonio di cui dispone un'impresa (capacità, talenti e aspirazioni, ecc.) è influenzato da esperienze eterogenee, e non solo dall'imprinting nazionale. Da qui la necessità di individuare un nuovo framework interpretativo. Quello scelto dai ricercatori del MIT si chiama "modello delle eredità dinamiche" e si configura come una delle numerose varianti della cosiddetta Competence-Based View, ramo a sua volta della Resource-Based View of the Firm. Rispetto alla scuola madre, secondo cui le imprese di successo sono tali perché nel corso della loro storia hanno prodotto competenze distintive, le varianti più recenti, a partire dalle dynamic capabilities di Teece e colleghi, privilegiano l'interesse per gli aspetti dinamici legati all'azione di combinazione e ricombinazione delle risorse e delle competenze aziendali in funzione dei cambiamenti che avvengono nell'ambiente. Se non fossero "dinamiche", le competenze sviluppate nel tempo, lungi dal costituire fonte di vantaggio competitivo, diverrebbero ostacolo allo sviluppo dell’impresa.
Ma seguiamo il percorso in cui si articola il libro, 400 pagine divise in sei parti e 12 capitoli. Le prime tre parti tracciano un ritratto delle "grandi forze che hanno modificato l'economia internazionale negli ultimi venti anni" (p. 174), tentando di fornire una mappatura delle rotte imboccate dalle aziende a produzione modulare. L'autrice illustra la frammentazione geografica e funzionale del sistema produttivo. Mentre le logiche produttive degli anni Ottanta assomigliavano a un kit per la produzione di un aeromodello (in cui ogni elemento aderisce perfettamente al successivo/adiacente e solo a quello), la produzione oggi si presenta - a livello globale - come il "gioco del Lego": le diverse parti e i diversi momenti del processo vengono ricombinati in un gran numero di combinazioni possibili che mostrano analoghe possibilità di successo.
L'analisi delle strategie con cui le imprese hanno governato la frammentazione sono oggetto della quarta e quinta parte. Qui, attraverso le testimonianze dei top manager e dei responsabili delle supply chain, si tenta di comprendere che cosa conduca le aziende a individuare ciò che deve essere prodotto "in-house", e ciò che va esternalizzato; cosa debba essere prodotto nel Paese di origine e cosa all’estero. In questo quadro vengono illustrati casi esemplari - Samsung, Sony, Zara, Gap, per citarne alcuni. Si consideri ad esempio il caso iPod della Apple, icona della mondializzazione: design statunitense, produzione delle componenti in Giappone e assemblaggio in Cina. E così anche la strategia di Dell: il colosso informatico compra tutti i componenti da aziende straniere, concentrando i suoi sforzi esclusivamente su definizione di prodotto, assemblaggio e distribuzione. Ma si individuano pure strategie alternative: Samsung, Motorola e Intel, per esempio, hanno conservato la maggior parte del processo produttivo all'interno, optando per l'integrazione verticale. Analogamente, gli autori evidenziano casi di frammentazione, o al contrario di integrazione, nei settori slow-tech, come il tessile o l'automobile. La catena americana di abbigliamento GAP esternalizza praticamente l'intera produzione, mentre Zara, il marchio spagnolo che registra nell'abbigliamento la maggior crescita mondiale, produce più di metà dei capi in patria.
La sesta parte completa il quadro con alcuni insegnamenti che si possono trarre dalla scoperta di una così "ampia gamma di scelte a disposizioni delle imprese" (p.20). Contrariamente all'opinione diffusa, la ricerca mostra come sia poco redditizia "la costruzione di business sui presunti vantaggi della manodopera a buon mercato" (p.314) e come siano al contrario vincenti le logiche di lungo termine che privilegiano lo sviluppo di eredità dinamiche, costituite da risorse distintive perseguite con la ricerca, la formazione permanente e l’innovazione continua. La mondializzazione può essere un’opportunità, se si è in grado di combinare core competences con risorse che esistono in altri luoghi. Certo, ciò comporta costi di aggiustamento che chiamano in causa le istituzioni pubbliche. E infatti una seconda lezione che gli autori traggono dal campo è diretta agli organismi pubblici, nazionali e sovranazionali, cui spetta l'onere di creare nuovi posti di lavoro, sostenendo la ricerca e l’innovazione dei privati, ma cui compete soprattutto lo sviluppo di politiche di welfare e di workfare che creino una rete per i lavoratori licenziati o a rischio.
La ricerca, come si può capire da questa rapida sintesi, è certamente un contributo prezioso, che consente, per la prima volta su così ampia scala, di avere importanti elementi di descrizione della varietà di strategie e disegni organizzativi. Tuttavia, essa presenta anche limiti notevoli: due in particolare ci sembrano quelli da segnalare.
L’ipotesi della convergenza, avversata dai ricercatori, non è realmente messa in dubbio dai dati prodotti. Mentre tale ipotesi (ma anche quella delle varietà nazionali dei capitalismi) è collocata sul polo generalizzante dell'analisi, il framework adottato dalla Berger si situa sul polo individualizzante. È ovvio che a livello di scelte strategico-manageriali di breve periodo diventano più evidenti le differenze tra imprese; l'ipotesi della convergenza è un modello in senso stretto, dunque qualcosa che può cogliere elementi di tendenza, ma che ovviamente si discosta dai singoli casi concreti. La stessa Berger riconosce peraltro che questa ricerca non ha prodotto evidenze forti contro la tesi della convergenza.
Tuttavia, anche ponendosi sul piano micro, dunque su un diverso livello di analisi, si devono individuare gravi carenze. In effetti, non è vero che si è esplorata la "ampia gamma di scelte a disposizione delle imprese" (p.20), almeno per due ragioni. In primo luogo, per valutare il modo con cui l'impresa si globalizza non è sufficiente limitarsi a osservare quali attività decentra, dove e a chi; occorre almeno un'analisi delle modalità di coordinamento di tali attività. In secondo luogo, manca una chiave interpretativa forte delle scelte operate dalle imprese esaminate: affermare che si tratta di conseguenze delle ri-elaborazioni delle competenze ereditate, non getta gran luce. Sarebbe opportuno cercare di capire come avvenga effettivamente questo processo di ri-produzione delle competenze. Gli strumenti analitici e metodologici capaci di cogliere e interpretare i processi organizzativi reali, al di là della logica della rappresentazione, non mancano nella letteratura organizzativa. Si spera che ulteriori ricerche siano in grado di andare più in profondità; per ora siamo grati ai ricercatori del MIT per il loro contributo a riportare su un piano più fattuale la riflessione sulla globalizzazione economica.
Reviews and Reflections
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser