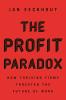L'ospite
L'Italia che compete. L'italian way of doing industry

E’ di grande attualità il dibattito sui problemi indotti dalla crisi internazionale e sulla capacità del nostro sistema nazionale di resistere agli evidenti segni di declino, manifestati in particolare dal tessuto industriale.
Gravi sono i sintomi di declino: la crescita modesta della produttività, la riduzione della competitività sui mercati internazionali dei prodotti italiani, segnalata peraltro da una significativa perdita di quota di mercato, la contrazione dell’occupazione e così via.
L’attualità e l’importanza del tema hanno richiamato l’attenzione di ricercatori e politici che hanno tentato di comprendere, oltre alla natura dei fattori causali della crisi, se - in un quadro così critico - esistono soggetti “locomotori” per l’economia italiana; ovvero soggetti che sappiano mantenere la loro competitività, che siano in grado di resistere ai contraccolpi della crisi e che possano fungere da traino per il sistema nazionale.
Le posizioni appaiono alquanto variegate; da un lato, non mancano soggetti che, contro il nanismo delle tipiche imprese nazionali, sostengono la necessità di valorizzare il ruolo propulsivo della grande impresa (anche grazie al recupero delle partecipazioni statali); altri, invece, avvalorano l’ipotesi di un possibile e spontaneo recupero di competitività delle tessuto delle piccole e medie imprese. Altri, vedono solo nella politica economica ed industriale la risoluzione ai problemi attuali.
Occorre tuttavia partire da un presupposto.
Il “Sistema Italia” si è più volte trovato a fronteggiare periodi di intensa crisi, affrontati dalle imprese con modelli di business assolutamente originali. L’analisi storica dell’evoluzione della struttura industriale italiana consente allora di offrire numerose risposte anche di fronte al contesto attuale.
L’analisi storica, infatti, ci offre un quadro conoscitivo longitudinale che:
a) assume una valenza interpretativa circa le luci e le ombre del tessuto economico nazionale;
b) evidenzia quale siano stati i soggetti “locomotori” che riescono ad avere successo e a svolgere un ruolo di traino per l’economia nazionale.
Come è noto, il percorso evolutivo del capitalismo italiano è stato connotato dall’avvicendarsi di quattro epoche: il primo capitalismo delle origini (il capitalismo delle fabbriche “tipo Mirafiori”), il secondo dell’impresa pubblica, il terzo dei distretti e delle piccole imprese riconducibile alla cd Terza Italia. Il “Quarto Capitalismo” è invece quello costituito da imprese di media dimensione che svolgono un ruolo sempre più incidente nell’economia nazionale, a fronte della crisi della grande impresa e alle difficoltà manifestate dalle piccole. Sul Quarto Capitalismo si sono attualmente prodotti numerose analisi di matrice economico-statistica (si pensi ai rapporti di Mediobanca) e studi di matrice aziendalistica anche finalizzati ad individuare i fattori di competitività di tale categoria di impresa.
Pertanto, si può affermare che le imprese italiane (alcune di esse) siano state in grado – anche nei momenti di crisi - di mantenere e rafforzare la propria competitività contribuendo così alla tenuta economica e alla proiezione internazionale del nostro Paese. Con riferimento all’attualità, esistono delle specificità nei modelli di business di quelle imprese che, appunto, mantengono la propria competitività?
A questa domanda, ha tentato di offrire una risposta l’insieme dei contributi raccolti nel volume Bufera F., De Michelis G., “L’Italia che compete. L’Italian ways of doing industry”, FrancoAngeli 2011, i quali raccolgono i risultati di una ricerca promossa dalla Fondazione Irso dell’Università di Milano Bicocca.
Una prima fondamentale domanda di ricerca riguarda se è legittimo parlare di un modello industriale italiano. A tale domanda risponde il capitolo curato da De Michelis, che dà avvio alla prima parte del volume, incentrata appunto sui “Modelli di Impresa”.
De Michelis individua come l’Italia sia stata sempre un caso di studio in quanto “anomalia” rispetto ad altri sistemi economici avanzati per la sua capacità di sviluppo mediante forme inedite: essa ha proposto diversi modelli quali la grande impresa a partecipazione statale, la grande impresa privata protetta, i distretti industriali, il Made in Italy, il miracolo delle medie imprese.
Un nuovo modello (ma frutto delle specificità delle imprese italiane) – definito come Italian way of doing industry – si sta affermando ed è quello delle imprese che hanno saputo mantenere e rafforzare anche nella crisi la propria competitività.
Si tratta di un modello che viene definito nei suoi tratti essenziali come segue: l’Italian way of doing industry è una combinazione di prodotto e servizio che crea una relazione di intimacy con i propri clienti; consiste in un governo delle imprese che coniuga gestione e innovazione (business design) e fa dell’innovazione il carattere distintivo dell’identità di impresa; presenta un radicamento nel territorio che non ostacola la proiezione internazionale delle imprese ma anzi le rende sinergici (Genius loci e internazionalizzazione).
Secondo De Michelis, questa attitudine non garantisce la salvezza del sistema italiano; solo se le imprese italiane riusciranno a fare il “salto”, proponendosi come innovatori a livello internazionale, analogamente a quanto fecero Zara e Ikea nei loro settori, si può auspicare un rilancio di competitività. L’autore, individua alcuni fattori che ostano al compimento di tale “salto”: la mancanza di coscienza di sé; di servizi (pubblici e privati) alle imprese all’altezza della sfida; di una politica industriale adatta alla nuova natura delle imprese.
In seguito, il volume presenta alcune specificità del sistema Italia quali i distretti (Stefano Micelli), le grandi imprese e il Made in Italy (Francesco Silva), le medie imprese (Daniele Marini), le piccole e medie imprese innovative (Riccardo Varaldo) ecc; modelli di impresa in cui si riscontra sempre più l’ Italian way of doing industry, sebbene declinato in modo diverso.
Federico Butera sviscera il modello dell’Italian way of doing industry; modello che è incentrato sulla ricerca di specificità su cinque item, quali il mercato, la strategia, l’anima dell’impresa, l’organizzazione e la qualità dell’imprenditore.
La prima dimensione viene affrontata dalle imprese italiane con riferimento alla “scelta di nicchia”, spesso internazionale. Le più frequenti strategie adottate dalle imprese italiane (seconda dimensione), spesso combinate fra loro, sono: focalizzazione e specializzazione; strategie di qualità (del prodotto, servizio, processo, immagine); strategie di customer orientation (personalizzazione, customer care, ascolto della customer experience); strategie di internazionalizzazione (reti commerciali, delocalizzazione della produzione, subforniture di parte della filiera, joint venture, alleanze, etc.). Le imprese italiane, infatti, difficilmente possono competere sul costo ma possono farlo sul brand, sulla qualità, sulla personalizzazione del prodotto, sull’ internazionalizzazione. Con riferimento all’organizzazione (terza dimensione), il sistema industriale italiano ha sviluppato in modo pionieristico - e continua a produrre -un repertorio di nuove forme organizzative (filiera, rete, distretti, sistemi integrati, ecc.): questa è una caratteristica e una risorsa dell’ Italian way of doing industry.
Con riferimento all’ “anima” (quarta dimensione), le imprese dell’Italian way of doing industry presentano un’elevata capacità dell’impresa di ottenere risultati e di cogliere opportunità, di governare i processi e di far leva sulle persone. A ciò, si associa la presenza di una buona qualità imprenditoriale, che sappia coniugare capacità di leadership industriale e azionariato in grado di attrarre capitali, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo.
Il lavoro prosegue con una parte dedicata alle politiche di valorizzazione dell’Italian way of doing industry, condotta in collaborazione con esponenti di Istituzioni economiche e imprenditoriali, incentrata sulle politiche di sostegno alla competitività, per la creazione di nuove imprese e per la managerializzazione di quelle esistenti.
Infine, sono analizzati settori e casi di imprese paradigmatici per l’Italian way of doing industry, presentati da esperti di settori e da manager/imprenditori di imprese italiane aventi tali peculiarità.
In conclusione, il focus degli studi qui presentati ha il pregio di individuare un nuovo modello - l’Italian way of doing industry, appunto – utile per interpretare i fattori che stanno alla base del successo di un nucleo di imprese che resistono anche di fronte alla crisi di competitività nazionale e che contribuiscono alla tenuta del Sistema Italia.
In questa prospettiva, la ricerca degli Autori è in grado di aprire la strada a nuovi studi aventi il compito di tradurre i concetti presentati nel libro in precise indicazioni di policy; indicazioni che dovrebbero essere funzionali ad individuare gli strumenti di politica industriale ed economica più appropriati per creare condizioni esterne “di contesto” (sistema formativo e della ricerca, sviluppo di istituzioni erogatrici di servizi reali, e così via) atte ad agevolare lo sviluppo dell’Italian way of doing industry e la diffusione di questo modello anche a imprese in crisi o start up. In questo senso, il volume è una risorsa sia per gli studiosi di management, di organizzazione e dei sistemi produttivi italiani, sia per i responsabili delle politiche di sviluppo economico.
Recensioni e Riflessioni
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser