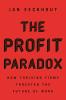L'ospite
L'impresa irresponsabile

Che il tema della responsabilità sociale di impresa sia all'ordine del giorno è oggi considerazione quasi scontata. La centralità di questo tema non discende solo dal vasto eco dei recenti scandali finanziari e industriali che hanno coinvolto imprese importanti come Parmalat, Enron o Lehman Brouthers giusto per citare le più note, ma anche, e in maniera più profonda, dal più generale e ampio dibattito circa quali debbano essere le finalità d'impresa. Questo dibattito è infatti cresciuto in anni recenti a seguito del fenomeno della globalizzazione che ha spinto alcune imprese a perseguire strategie di delocalizzazione verso aree a bassa protezione sociale o a bassa tassazione o verso regioni con deboli standard ambientali e ha preso nuovo vigore a seguito della recente crisi finanziaria che ha messo in luce come il modo di operare di interi comparti industriali (ad esempio l'investment banking) potesse mettere in difficoltà l'intera economia mondiale.
E' proprio per contribuire a questo dibattito che Luciano Gallino, professore emerito di sociologia all'università di Torino, ha deciso di far uscrie la seconda edizione del volume dal titolo provocatorio, ma giustificato nel contesto dell'analisi svolta, "L'impresa irresponsabile". Ci pare opportuno rilevare che il volume mantiene le promesse che il titolo sembra evocare: Gallino non teme di mettere in discussione nessuno degli assunti che una parte rilevante della contemporanea cultura aziendalistica sulle finalità d'impresa, ed in particolare quella di matrice anglosassone, propone come fondamenti della propria analisi. Del resto Gallino, avendo lavorato in Olivetti ai tempi in cui questa impresa era diretta dall'Ingegnere Adriano, ha avuto un'esperienza diretta e quindi una conoscenza profonda di imprese profondamente responsabili che si sono distinte per l'impegno sociale ma anche per la capacità di innovazione. Il libro si apre con una definizione di impresa irresponsabile ovvero di quella impresa che, al di là degli elementari obblighi di legge, suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata né all'opinione pubblica in merito alle conseguenze in campo economico, ambientale e sociale delle sue attività. Il termine, coniato per la prima volta dal Presidente americano Theodore Roosevelt in un suo saggio del 1913, fa dunque riferimento non solo a tutte quelle imprese oggetto di scandali finanziari ma anche a quelle che hanno comportamenti che, ancorchè rispettosi della forma delle leggi, ne violano lo spirito o che trasferiscono all'estero attività che nei paesi d'orgine non sarebbero permesse. Il volume è ricco di descrizioni dettagliate di comportamenti irresponsabili da parte delle imprese, ma la parte più interessante riguarda la critica serrata a quello che Gallino definisce il "capitalismo manageriale finanziario" ovvero a quel capitalismo che, in nome della massimizzazione del valore di borsa, favorisce comportamenti irresponsabili da parte delle aziende. In particolar modo, la critica di Gallino si concentra sul principio della massimizzazione del valore azionario visto come unico criterio di valutazione delle strategie delle imprese. In base a questo assunto, tipico della dottrina anglosassone, teoricamente l'impresa non è altro che uno strumento che andrebbe gestito dai managers per garantire agli azionisti la massimizzare del loro investimento. Gallino illustra molto chiaramente come questo principio sia divenuto nel tempo l'assunto di base dell'intero sistema di governo delle grandi corporation americane e come questo principio si sia diffuso progressivamente a livello mondiale a larga parte delle grandi imprese multinazionali. Da questo punto di vista la globalizzazione ha costituito un potente fattore di diffusione dei comportamenti irresponsabili attaverso due meccanismi di trasmissione. Da un lato, costringendo gli Stati ad abbassare gli standard sia a livello di regolamentazione generale delle corporation, che a livello di imposizione fiscale che di regole sociali e di sicurezza. Questo progressivo deterioramento della normativa è avvenuto nel nome di una concorrenza regolamentare tra gli Stati che ha portato ad un generale abbassamento degli standard legislativi. Il secondo meccanismo di trasmissione è costituito dall'aumento del peso relativo delle grandi multinazionali il cui potere economico - rispetto a quello degli Stati - è aumentato nel tempo riducendo lo spazio di manovra del potere politico. Questo fenomeno ha contributo ad ostacolare il già difficile processo di definizione di un set di regole comuni a livello sovranazionale che, garantendo il principio del libero mercato, permettessero di creare un patrimonio comune di regole che tutte le imprese fossero obbligate a seguire indipendentemente dalla localizzazione scelta.
Questa prima parte del volume, incentrata sulla critica del sistema del capitalismo manageriale finanziario, risulta estremamente interessante anche perché riccamente documentata e si presta almeno a tre ordini di commenti. Il primo è che, per un conoscitore della dottrina aziendalistica italiana ed europea, la critica di Gallino sulle conseguenze dell'adozione univoca del criterio di massimizzazione del valore azionario d'impresa costituiscono una realtà ben nota. Il pensiero aziendalistico europeo in generale ed italiano in particolare hanno infatti sempre adottato una visione più articolata della impresa, intesa come istutuzione complessa e che ha molteplici ed articolati obiettivi. In secondo luogo, Gallino non sembra trarre fino in fondo le conclusioni che emergono dalla sua analisi circa gli effetti della globalizzazione sulla diffusione del principio di massimizzazione del valore azionario. Se questo principio si è affermato a livello mondiale, ciò è dovuto in parte anche al fatto che il modello alternativo, più articolato e comprensivo di una molteplicità di obiettivi, tipico del capitalismo europeo, non si è affermato in ragione delle debolezze dell'Europa. Questa, non svolgendo un ruolo politico a livello mondiale, non è stata infatti capace di farsi promotrice di un modello alternativo a quello americano che dunque si è affermato universalmente in maniera pressochè incontrastata. Infine, è opportuno sottolineare che nel libro appare del tutto sfumato il ruolo propulsivo che le imprese in generale e quelle internazionali in particolare hanno comunque avuto nel promuovere la crescita mondiale anche in aree del mondo che, come la Cina o l'India, erano, fino a poco tempo fa, rimaste ai margini dello sviluppo economico. Questo concetto è invece importante e andrebbe sempre sottolineato da qualsiasi studioso d'impresa. La parte conclusiva del volume invece si concentra sul tema di come sia possibile integrare il modello della corporate social responsibility nel governo dell'impresa. Il tema è ovviamente fondamentale ma, in mancanza di una visione istituzionalistica dell'impresa, le proposte avanzate paiono meno convincenti e interessanti rispetto all'analisi sviluppata nella prima parte del volume, quella che potremo definire destruens. In ogni caso il libro pone problemi e propone spunti di riflessione che ogni studioso d'impresa e ogni manager oggi si trova ad affrontare. Una lettura dunque utile e stimolante per tutti.
Recensioni e Riflessioni
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser