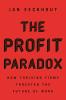L'ospite
El desafío del comercio justo en América Latina. El caso del sector artesanal

Il volume “El desafío del comercio justo en América Latina. El caso del sector artesanal” è il risultato di una cooperazione tra università dei paesi sviluppati e del terzo mondo. Dal 2000, l’Università di Genova (attraverso il Dipartimento di Tecnica Economica e Aziendale) sta dando il suo aiuto allo start up di una nuova università peruviana, situata nella zona nord di Lima, una zona vasta ma con forti caratteristiche di povertà e marginalità. La nuova università è ormai operativa a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda la didattica che la ricerca. Da quest’ultimo punto di vista, sono state effettuate diverse ricerche in collaborazione: fra di esse assume un particolare significato quella volta a confrontare le filiere tradizionali di internazionalizzazione con quelle legate al commercio equo e solidale. Il lavoro è stato il risultato della partecipazione ad un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Cofinanziamento PRIN 2003 – MIUR) dal titolo “Commercializzazione dei prodotti del terzo mondo nei mercati avanzati. Confronto fra efficienza e efficacia delle filiere tradizionali e delle filiere alternative”, che ha visto partecipare l’Università di Roma Tor Vergata (capofila), l’Università di Napoli Parthenope e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Per due anni una unità di ricerca facente capo all’Università di Genova e con base locale presso l’Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima ha raccolto materiale e fatto indagini dirette su sette paesi dell’America Latina: Perù, Argentina, Cile, Bolivia, Messico, Ecuador e Brasile. Ne è nato un profilo – fino ad oggi sconosciuto – dei lineamenti del commercio equo e solidale e delle sue tendenze di sviluppo. Il libro, pubblicato dal Fondo Editorial della Universidad Católica Sedes Sapientiae, è coordinato da Clara Caselli (Università di Genova) e Stefania Mittiga e prevede altresì la collaborazione di Laure Jongejean. Mittiga è stata borsista dell’Università di Roma La Sapienza e ricercatrice dell’Università di Lima ed è tuttora membro del tavolo di concertazione del commercio equo e solidale in Perù, mentre Jongejean, dopo avere fatto studi di specializzazione in Belgio, è ora studiosa e consulente nel campo del commercio equo e solidale: entrambe hanno fatto parte dell’unità di ricerca che ha lavorato presso l’Università di Lima.
Il volume si apre con un saggio che fissa alcuni aspetti del quadro teorico di riferimento. Viene messo a tema il contributo che l’internazionalizzazione – soprattutto mercantile – può dare allo sviluppo del terzo mondo. La tesi di fondo è che volgono ormai al termine le storiche contrapposizioni di tipo ideologico ed è sempre più chiaro che “sviluppo è il nuovo nome dell’etica nelle relazioni internazionali”. Le relazioni “virtuose” sono quelle che contribuiscono alla creazione della rete del valore a livello globale: il commercio equo e solidale può essere una delle forme adottate, ma la sua perdurante marginalità rispetto al complesso degli scambi internazionali ne sottolinea il prevalente ruolo di “testimonianza”, mentre appare interessante andare a cercare quali altre modalità possano soddisfare condizioni di eticità nelle relazioni internazionali. Se ne individuano tre, rappresentate dalla formazione di reti e alleanze di imprese anche di diverse dimensioni e appartenenti a paesi differenti, da alcune forme di responsabilità sociale delle imprese, dalle alleanze per lo sviluppo del capitale umano.
La seconda parte è dedicata ad una analisi approfondita del caso peruviano, relativamente al settore artigianato. Il motivo della scelta di questo settore, non tradizionale per quello che concerne il commercio equo e solidale che in larga parte concerne il settore agricolo e prodotti derivati (come il caffè), si ricollega alla visione ricordata in precedenza: l’artigianato implica infatti una maggior creazione di valore in loco; è contiguo rispetto a settori industriali come il tessile-abbigliamento, l’oreficeria, i prodotti per la casa; consente il rispetto e la valorizzazione delle tradizioni e culture locali.
Nel caso del Perù il commercio equo e solidale di prodotti artigianali appare in crescita costante, ha raggiunto una percentuale ragguardevole delle esportazioni, ma rimane di importo scarsamente significativo sul complesso delle esportazioni peruviane.
Il confronto fra le filiere fa emergere una notevole differenza rispetto ai circuiti tradizionali in cui – in molti casi – non esiste una relazione diretta tra produttore e mercato. Anche nelle forme meno avanzate, infatti, gli artigiani e le loro forme di organizzazione si vedono riconosciuto un maggior valore e beneficiano di canali di commercializzazione più corti di quelli tradizionali. Nelle forme più avanzate vengono aggiunti via via servizi che facilitano l’accesso ai mercati e si sperimentano forme nuove come l’e-commerce, mentre si fanno strada logiche di rete e di certificazione dei prodotti.
Interessante è anche l’analisi delle forme alternative diverse dal commercio equo e solidale: la responsabilità sociale sta facendo i suoi primi passi in Perù, ma ha certo molti margini di sviluppo, data la forte diffusione di settori come quello minerario, finanziario e delle telecomunicazioni dove - grazie anche alla presenza in diversi casi di capitali stranieri - sta crescendo significativamente la sensibilità ad iniziative sociali. Ad ogni modo le iniziative probabilmente di gran lunga più interessanti sono rappresentate dalla creazione di reti: a volte sono le piccole imprese peruviane che si organizzano in questo modo (a volte le organizzazioni non governative fanno da catalizzatore) oppure imprese medie e medio-grandi creano una sorta di costellazione per rafforzare la loro presenza internazionale oppure ancora le alleanze nascono per iniziative, più o meno strutturate e formalizzate, che vedono la presenza di imprese peruviane e straniere.
La terza parte contiene sei profili paese, meno approfonditi dello studio sul Perù ma condotti con criteri comparativi ed estesi non solo al settore artigianale. I materiali usati sono totalmente inediti e sono stati raccolti in due anni con un paziente lavoro di ricerca e attraverso diversi viaggi, soprattutto in occasione degli incontri annuali delle reti del commercio equo e solidale. Non in tutti i paesi le iniziative sono nate nello stesso momento, ma lo sviluppo recente data in tutti i casi dagli anni successivi al 2000. In alcuni casi la struttura prevede raggruppamenti di produttori, in altri imprese di commercializzazione, in altri ancora sono presenti entrambe le tipologie. Nei casi più avanzati cominciano ad emergere le iniziative di certificazione, anche se normalmente la posizione verso le certificazioni ufficiali (“del nord”) è piuttosto critica. Sempre più diffuse sono le reti latino americane, nonché varie forme di e-commerce, inoltre crescono anche in America Latina le botteghe e ci si pone il problema di spingere la nascita di flussi sud-sud. A parte il caso del Brasile non sono invece molto sentite le tematiche del rapporto con il settore pubblico. Un’altra tendenza interessante è data dall’allungamento della filiera: in alcuni casi forme di turismo alternativo sostenibile si affiancano alle precedenti, producendo una integrazione di redditi e comunque stimolando la creazione di valore in loco.
Nonostante tutti gli sforzi compiuti, il settore del commercio equo e solidale non sembra però riuscire ad uscire dalla sua “nicchia”: i motivi sono legati alla difficoltà di produrre quantità adeguate e secondo le cadenze temporali richieste dal mercato, ma soprattutto alle carenze di tipo qualitativo e al gap di efficienza di questi operatori. Anche se appaiono interessanti i tentativi di formazione di reti, processi di certificazione, adozione di tecnologie più avanzate, allargamento del mercato anche nel sud del mondo, non sembra che per il momento emergano soluzioni risolutive. L’attuale fase è vista dal movimento latino americano di commercio equo in modo abbastanza variegato e contraddittorio: per alcuni occorre aprirsi di più all’esterno ed anche verso organizzazioni con decisa connotazione profit (grandi importatori, grande distribuzione organizzata), per altri invece questa apertura ne snaturerebbe le caratteristiche e sarebbe pertanto da evitare; in quest’ultimo caso il futuro passa attraverso il rafforzamento delle sinergie con il mondo dell’economia solidale in tutte le sue articolazioni (consumo etico, turismo responsabile, economia di baratto, ecc.). I termini del dibattito sono in parte simili a quanto avviene nel nord, ma se ne discostano soprattutto per l’emergere in diversi casi di una vivace dialettica con il “nord” medesimo. Ad ogni modo, è del tutto evidente che la seconda strada è una strategia di “nicchia etica”, il cui futuro e le possibilità di successo appaiono non particolarmente favorevoli.
Recensioni e Riflessioni
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser