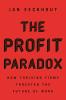L'ospite
Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti

Una ricerca approfondita, sistematica e decisamente ambiziosa quella compiuta da Enzo Rullani che ha dato vita a due volumi (Economia della conoscenza e La fabbrica dell’immateriale) autonomi, ma complementari, dedicati al ruolo della conoscenza nella prassi manageriale e in particolare nel processo di creazione del valore. Il primo dei due testi, in particolare, rappresenta un vero e proprio itinerario alla ri-scoperta della conoscenza, con l’intento dichiarato di colmare il gap esistente tra le sue rappresentazioni teoriche, che la relegano in un ruolo marginale assimilandola ad un qualunque fattore produttivo (capitale, lavoro, energia) e la percezione pratica nell’economia reale, che la vede da tempo ormai protagonista di fatto dell’agire manageriale.
La conoscenza è per Rullani un fattore produttivo sui generis, non riconducibile ad altro e per questa sua natura essa genera valore attraverso vie molto diverse da quelle tipiche dei fattori produttivi considerati dall’economia tradizionale, le principali delle quali deriverebbero proprio dalle sue caratteristiche peculiari: la capacità di moltiplicare gli usi e di conseguenza il valore creato; la capacità di interpretare le esperienze in funzione del coinvolgimento soggettivo ed infine la capacità di auto-regolare i rapporti sociali tra gli attori, con positive ripercussioni in termini di reciproca interdipendenza, di condivisione della conoscenza e con riferimento alle conseguenze che la sua applicazione può determinare nel contesto competitivo.
La tendenza diffusa ad assimilare la conoscenza ai fattori produttivi tradizionali impedisce, secondo Rullani, di coglierne appieno il potenziale.
Occorre dunque riformulare le teorie consolidate, che mal si adattano ad interpretare il mutato scenario, introducendo nuovi paradigmi, che prendano le mosse dalle proprietà stesse della conoscenza. Anche le elaborazioni concettuali che affrontano il tema descrivendo l’era della conoscenza in negativo, per differenza rispetto alle teorie consolidate, non sarebbero adeguate a cogliere la portata del cambiamento.
Occorre, in sostanza, procedere ad un’azione di aggiornamento della teoria ad una realtà che è già mutata, ma con ritmi e linee evolutive radicalmente diverse da quelle a cui siamo abituati.
Il lavoro e il progetto entro il quale esso si inserisce vanno, dunque, nella direzione di tracciare una netta demarcazione, anche in termini disciplinari, tra la nuova economia della conoscenza e la tradizionale economia neoclassica dei fattori produttivi, che non sarebbe in grado di accogliere le novità legate alla produzione di valore a mezzo di conoscenze.
Una volta individuati i drivers tramite i quali la conoscenza consente di creare valore e i mediatori cognitivi che consentono la codificazione e la condivisione della conoscenza, connettendo i contesti di produzione con quelli di potenziale applicazione, lo studio ricostruisce un modello paradigmatico di interpretazione del mutato scenario attraverso l’indagine approfondita dei tratti distintivi della risorsa conoscenza e delle sue ripercussioni nella realtà economica.
L’opera di Rullani, corposa e meticolosa nell’indagare la letteratura e la prassi manageriale, si presenta, come di consueto, rigorosa e creativa al tempo stesso. L’ortodossia accademica storcerà forse il naso di fronte ad un linguaggio talvolta sopra le righe e a tesi che potremmo anche definire ardite nel loro porsi in netta discontinuità rispetto alle dottrine economiche tradizionali, ma che costituiscono un contributo lungimirante al dibattito scientifico.
Recensioni e Riflessioni
- Marco Vitale
- Vittorio Coda
- Davide Calandra
- Martin Dege
- Irene Strasser